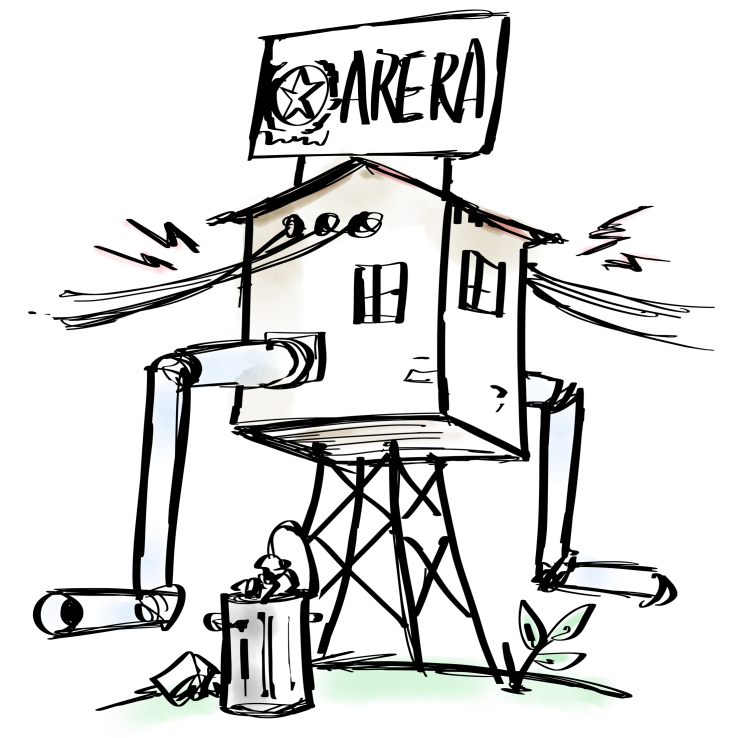I prezzi del petrolio e del gas sono scesi rispetto ai
valori della prima decade di febbraio [2025]. Riguardo ai prezzi gas a termine,
probabilmente una ragione è che sembra sempre meno un tabù la prospettiva di
una ripresa delle importazioni europee via tubo dall’Ucraina, che spiazzerebbe
il più costoso gas via nave in particolare dagli USA proprio mentre
l’amministrazione Trump pianifica di aumentarne la capacità.
I tempi della politica però sono più lenti di quelli dei
mercati spot, e questa settimana il Parlamento italiano inizia le audizioni in
vista della conversione in legge del decreto di contenimento delle bollette,
che abbiamo menzionato solo en passant la scorsa settimana.
Gli elementi principali della misura sono:
Introduzione di un bonus di 200 € per tutti i clienti
domestici di elettricità con ISEE inferiore a 25.000 €, che si aggiunge al
bonus energia già in vigore per clienti con ISEE più basso.
Si tratta di una soluzione ben disegnata, perché così come
il bonus a cui si aggiunge non è indiscriminata né disincentiva all’efficienza
nei consumi, visto che i soldi arrivano anche se si consuma meno.
Introduzione per Acquirente Unico della possibilità di approvvigionarsi
di energia anche con contratti bilaterali e non solo sulla borsa elettrica.
Acquirente Unico è un broker pubblico di elettricità che la
compra all’ingrosso per rifornire oggi i clienti cosiddetti vulnerabili, che
continuano ad aver diritto a una tariffa a condizioni standard paradossalmente
più soggetta alle fluttuazioni di prezzo rispetto a buona parte delle offerte
sul mercato libero. Questa norma appunto mira a rendere possibile la fissazione
di prezzi meno volatili anche per i clienti vulnerabili. Se può sembrare una
buona idea, in realtà ci sono ottime ragioni per cui il legislatore aveva invece
deciso l’opposto anni fa, imponendo ad Acquirente Unico di acquistare solo sulla
borsa elettrica, che è un mercato regolato e trasparente per costruzione.
Ragioni volte ad evitare comportamenti arbitrari da pare di un’azienda pubblica
nel negoziare bilateralmente condizioni che potrebbero rivelarsi sfavorevoli in
caso di prezzi di borsa in discesa successivi alla stipula dell’accordo.
Azzeramento per 6 mesi per i consumatori non domestici di
dimensioni rilevanti (potenza maggiore di 14,5 kW) della principale componente
regolata delle bollette elettriche.
Qui da un lato per una volta si interviene a favore di una
categoria (i clienti business non energivori) che è tra le più maltrattate del
sistema regolato delle bollette, bene quindi, dall’altro lo si fa senza
introdurre alcun incentivo all’efficienza dei consumi, il che è male.
Un sistema – da stabilire con norme successive – di
restituzione a “famiglie e microimprese vulnerabili” del maggiore gettito IVA
legato all’aumento dei prezzi del gas.
Vedremo come verrà attuata, ma è una buona idea perché non
taglia indiscriminatamente l’IVA sull’energia come fu fatto in passato, ma nello
stesso tempo ne calmiera l’impatto attraverso una restituzione selettiva.
Infine il decreto prevede che l’Autorità per l’Energia
introduca nuove norme per aiutare la trasparenza e confrontabilità delle
offerte commerciali ai clienti domestici.
Se per confrontabilità si intende disponibilità di tariffe
standard semplificate, esistono già le offerte cosiddette “Placet”, attraverso
cui tutti i fornitori devono proporre una formula facile a prezzo fisso o
variabile rispetto all’andamento del mercato all’ingrosso. Questo decreto potrebbe
essere un’occasione per aggiungere due nuove opzioni:
Una con prezzi dinamici che davvero rispecchino quello
dell’ora specifica di consumo, il che darebbe incentivo a consumare quando
l’abbondanza di fonti rinnovabili abbassa il prezzo, e non quando la necessità
di accendere centrali a gas lo alza (cosa che tipicamente succede nelle prime
ore serali).
L’altra che preveda un impegno di lungo termine di acquisto
esclusivo da impianti da fonti rinnovabili con emancipazione dal prezzo del gas.
Questa renderebbe possibile quel “disaccoppiamento” con il prezzo del gas di
cui si parla tanto ultimamente.
In entrambi i casi il consumatore avrebbe più strumenti per
favorire transizione ed economicità.
Se la norma invece prelude a limitazioni alla creatività dei
fornitori nell’assecondare le esigenze dei clienti, allora potrebbe essere
controproducente.
Ringrazio per questa puntata Marco Ballicu. Ogni
eventuale errore è però mio, come sempre.I prezzi del petrolio e del gas sono scesi rispetto ai
valori della prima decade di febbraio [2025]. Riguardo ai prezzi gas a termine,
probabilmente una ragione è che sembra sempre meno un tabù la prospettiva di
una ripresa delle importazioni europee via tubo dall’Ucraina, che spiazzerebbe
il più costoso gas via nave in particolare dagli USA proprio mentre
l’amministrazione Trump pianifica di aumentarne la capacità.
I tempi della politica però sono più lenti di quelli dei
mercati spot, e questa settimana il Parlamento italiano inizia le audizioni in
vista della conversione in legge del decreto di contenimento delle bollette,
che abbiamo menzionato solo en passant la scorsa settimana.
Gli elementi principali della misura sono:
1) Introduzione di un bonus di 200 € per tutti i clienti
domestici di elettricità con ISEE inferiore a 25.000 €, che si aggiunge al
bonus energia già in vigore per clienti con ISEE più basso.
Si tratta di una soluzione ben disegnata, perché così come
il bonus a cui si aggiunge non è indiscriminata né disincentiva all’efficienza
nei consumi, visto che i soldi arrivano anche se si consuma meno.
2) Introduzione per Acquirente Unico della possibilità di approvvigionarsi
di energia anche con contratti bilaterali e non solo sulla borsa elettrica.
Acquirente Unico è un broker pubblico di elettricità che la
compra all’ingrosso per rifornire oggi i clienti cosiddetti vulnerabili, che
continuano ad aver diritto a una tariffa a condizioni standard paradossalmente
più soggetta alle fluttuazioni di prezzo rispetto a buona parte delle offerte
sul mercato libero. Questa norma appunto mira a rendere possibile la fissazione
di prezzi meno volatili anche per i clienti vulnerabili. Se può sembrare una
buona idea, in realtà ci sono ottime ragioni per cui il legislatore aveva invece
deciso l’opposto anni fa, imponendo ad Acquirente Unico di acquistare solo sulla
borsa elettrica, che è un mercato regolato e trasparente per costruzione.
Ragioni volte ad evitare comportamenti arbitrari da pare di un’azienda pubblica
nel negoziare bilateralmente condizioni che potrebbero rivelarsi sfavorevoli in
caso di prezzi di borsa in discesa successivi alla stipula dell’accordo.
3) Azzeramento per 6 mesi per i consumatori non domestici di
dimensioni rilevanti (potenza maggiore di 14,5 kW) della principale componente
regolata delle bollette elettriche.
Qui da un lato per una volta si interviene a favore di una
categoria (i clienti business non energivori) che è tra le più maltrattate del
sistema regolato delle bollette, bene quindi, dall’altro lo si fa senza
introdurre alcun incentivo all’efficienza dei consumi, il che è male.
4) Un sistema – da stabilire con norme successive – di
restituzione a “famiglie e microimprese vulnerabili” del maggiore gettito IVA
legato all’aumento dei prezzi del gas.
Vedremo come verrà attuata, ma è una buona idea perché non
taglia indiscriminatamente l’IVA sull’energia come fu fatto in passato, ma nello
stesso tempo ne calmiera l’impatto attraverso una restituzione selettiva.
5) Infine il decreto prevede che l’Autorità per l’Energia
introduca nuove norme per aiutare la trasparenza e confrontabilità delle
offerte commerciali ai clienti domestici.
Se per confrontabilità si intende disponibilità di tariffe
standard semplificate, esistono già le offerte cosiddette “Placet”, attraverso
cui tutti i fornitori devono proporre una formula facile a prezzo fisso o
variabile rispetto all’andamento del mercato all’ingrosso. Questo decreto potrebbe
essere un’occasione per aggiungere due nuove opzioni:
Una con prezzi dinamici che davvero rispecchino quello
dell’ora specifica di consumo, il che darebbe incentivo a consumare quando
l’abbondanza di fonti rinnovabili abbassa il prezzo, e non quando la necessità
di accendere centrali a gas lo alza (cosa che tipicamente succede nelle prime
ore serali).
L’altra che preveda un impegno di lungo termine di acquisto
esclusivo da impianti da fonti rinnovabili con emancipazione dal prezzo del gas.
Questa renderebbe possibile quel “disaccoppiamento” con il prezzo del gas di
cui si parla tanto ultimamente.
In entrambi i casi il consumatore avrebbe più strumenti per
favorire transizione ed economicità.
Se la norma invece prelude a limitazioni alla creatività dei
fornitori nell’assecondare le esigenze dei clienti, allora potrebbe essere
controproducente.
Ringrazio per questa puntata Marco Ballicu. Ogni
eventuale errore è però mio, come sempre.