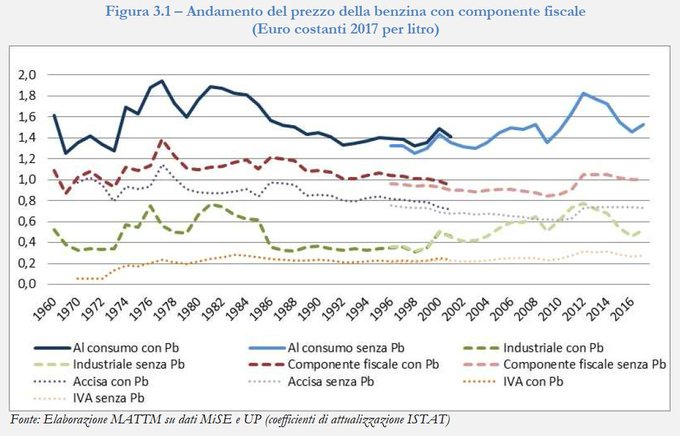Puntata 530
Un articolo
sull’Economist di fine maggio 2022 fa il punto sull’uso dei trasporti
pubblici a Londra, dove è stata appena inaugurata la nuova linea di metro
“Elisabeth line”.
La gente ha
ricominciato a usare il trasporto pubblico tradizionale a Londra dopo il Covid?
La risposta è: non come prima. In particolare la metro londinese ha oggi il 40%
di utenti in meno rispetto a prima del Covid. Lo stesso vale, in misura minore,
per bus e treni.
Ma siccome
anche l’auto privata è usata un po’ meno nei giorni di lavoro, la domanda
inevitabile è dove se ne siano andati gli utenti del trasporto pubblico di Londra.
La risposta è
che in parte lavorano ancora da casa (e verosimilmente ormai continueranno a
farlo), in parte usano mezzi di mobilità leggera (come le bici) anche
condivisa, anche sfruttando la nuova rete di ciclabili di cui la città, come
tante altre al mondo, si sta dotando.
L’ultimo
rapporto dell’osservatorio nazionale italiano della sharing mobility (purtroppo
con dati solo fino al 2020, link sotto) mostra anche da noi un aumento geometrico di chi si
muove con bici, scooter, auto o altro condivisi.
L’azienda dei
trasporti di Scozia vedendo numeri simili nella sua area ha già cancellato
alcuni degli investimenti di potenziamento che erano previsti.
Andiamo dunque
verso la fine dei trasporti pubblici? Io non credo, ma credo che probabilmente
andiamo verso una loro trasformazione, trainata anche dalla disponibilità di
nuove tecnologie.
Intanto, la
domanda di trasporti pubblici o condivisi avrà meno la natura di pendolarismo
urbano a orari prefissati, almeno se sarà anche la flessibilità degli orari
d’ufficio e non solo la possibilità di lavorare da casa ad affermarsi. E con
meno intensità di viaggiatori di punta, la necessità di capacità delle
infrastrutture si riduce anche a parità di passeggeri.
C’è nello
stesso tempo il fenomeno della diminuzione dell’uso di auto private, che prima
o poi, quando anche i nostri governi accetteranno di non poter ad libitum
foraggiare questo settore fuori da ogni razionalità, comporterà una nuova
domanda di trasporto anche tra piccoli centri che raramente è economico
soddisfare con il treno. Su questo Derrick si è già avventurato in previsioni
che sono facilmente rintracciabili al link in fondo a questa pagina.
Intanto
qualcosa si muove a Roma riguardo all’infrastruttura ferroviaria: la stazione Vigna
Clara pare proprio che inizierà a funzionare da giugno con treni per collegarla
a Valle Aurelia. A chiudere a Nord-Est l’anello ferroviario della città manca
però la relativamente breve tratta da Vigna Clara a est fino alla zona di
stazione Nomentana (o all vicina stazione-fantasma di Val D’Ala) passando per
quella di Tor Di Quinto che oggi serve la vecchia ferrovia da Roma piazzale Flaminio
a Viterbo.
Puntata 474
Vediamo se qualcuno degli ascoltatori di Derrick si ricorda di
una cosa che io leggevo già mi pare alla fine degli anni Ottanta in qualche
periodico, forse Quattroruote. Era un apparecchio basato su tecnologia di
comunicazione radio fatto per essere installato in macchina, simile a un
Telepass ma non era un telepass: era un lettore di segnali in arrivo da
postazioni fisse o mobili sulla strada per avvertire di pericoli dovuti a
contingenze o alla conformazione della strada. Mi pare di ricordare che fosse
un progetto che coinvolgeva ANAS o ACI, o entrambi. Si vide la pubblicità per
qualche tempo, poi prevedibilmente scomparve: la cosa era troppo avanti e richiedeva
un livello minimo di diffusione dell’infrastruttura per essere appetibile all’utente
privato, ma quella stessa infrastruttura era difficile che si sviluppasse senza
l’interesse dei clienti della scatolina. Un classico circolo vizioso che accompagna
spesso l’introduzione di nuovi standard o infrastrutture.
 |
| Autostrada ad Abu Dhabi (foto Derrick) |
Si trattava però davvero di un’iniziativa lungimirante. Lo
sviluppo, parziale fallimento e reindirizzamento delle tecnologie di guida
autonoma di veicoli stradali degli ultimi anni a mio avviso lo dimostra: n
essuna intelligenza artificiale oggi è in grado
di avere una cognizione abbastanza olistica e analogica da poter condurre un
veicolo in ambienti non protetti su strada, se non con una dovizia di sensori
che sfiora il ridicolo (noi guidiamo con due occhi e orecchie e mentre pensiamo
a altro, le auto a guida autonoma hanno bisogno di telecamere ovunque, radar,
sensori di distanza – anche se è probabilmente vero che noi siamo più fallibili).Di conseguenza un filone importante degli investimenti
nella guida autonomia si è spostato verso la mappatura di estremo dettaglio delle
strade, servizio che si sta configurando come una vera e propria infrastruttura
di interesse pubblico complementare alle strade stesse.
Uno dei settori più interessanti del piano di ripresa e
resilienza mi sembra siano proprio i trasporti, suddivisi tra almeno due dei
capitoli (detti ”missioni”) del Piano, il secondo (“Rivoluzione verde e
transizione ecologica”) e naturalmente il terzo (infrastrutture per una mobilità
sostenibile), in cui è evidente la quasi dicotomia (o più ottimisticamente
complementarietà) tra aspirazione a collegamenti veloci tra hub e ramificazione
locale dei trasporti.
Per un Paese come il nostro, di borghi che per quanto sempre
meno popolati sono sede imprescindibile di bellezza, cultura e attrazione – e dopo
il covid forse hanno anche qualche prospettiva di un ripopolamento residenziale
da parte delle classi produttive oggi urbane – credo le nuove tecnologie dei
trasporti e quindi le nuove forme di trasporto pubblico, saranno decisive.
Difficilmente per motivi di costi un treno potrà mai
arrivare in un borgo rinascimentale collinare di 2000 anime. E gli autobus di
linea difficilmente possono passare più di un paio di volte al giorno in ognuno
degli innumerevoli borghi meno vicini al capoluogo di interconnessione
ferroviaria. È verosimile quindi che la soluzione siano forme di uso condiviso
di veicoli in grado di spostarsi da soli a seconda delle richieste degli
utilizzatori e adatti a funzionare in modo collettivo. Una sorta di car sharing
in pool e senza conducente, navette collettive interurbane flessibili che rispondano
alle chiamate degli utenti accorpandoli contemperando efficienza e tempi di
attesa, che possa costare poco in totale rispetto alle linee di bus e che
magari riceva per questo contributi pubblici nel momento in cui vi si sostituisca.
Anche a questo servirà l’infrastruttura per la guida autonoma.
Link: